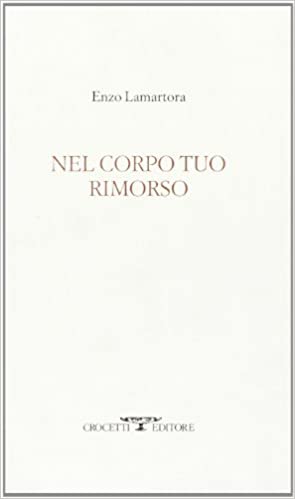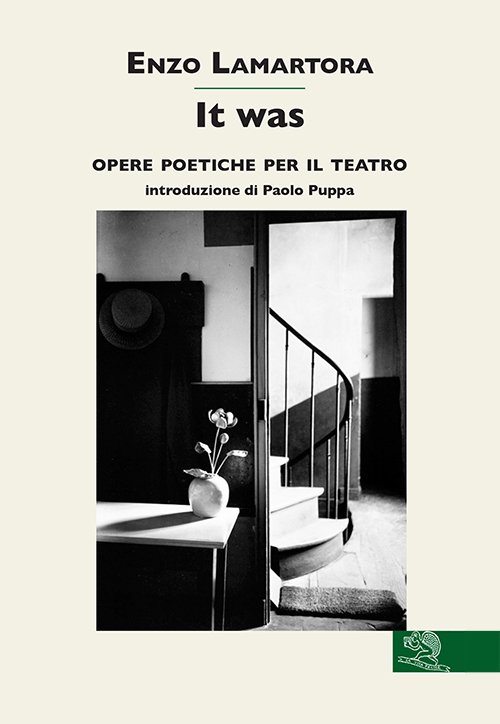- La notte che eterea effonde, “Passages” n. 1 maggio-agosto 2002, Crocetti, Milano 2002
- Il viaggio in Normandia, “Passages”n. 2 settembre-dicembre 2002, Crocetti Editore, Milano 2002
- Nel corpo tuo rimorso, Crocetti Editore, Milano 2002
- La dimensione della perdita. Poesie 2005 – 2014, Crocetti Editore, Milano 2016
- It Was, La Vita Felice, Milano 2017
- The Autumn of love, traduzione M. Palma, Gradiva Publications, New York 2018
- Disamore, La Vita Felice, Milano 2020
- Das aussmass des verlusts, traduzione H. Raimund, Pen LOCKER, Vien 2022
- Attendersi di là, La Bussola Edizioni, Roma, 2022
- Rosso. Interludio, Raffaelli Editore, Rimini 2022
- It Was, Traduzione Michael Palma, Fomite Press, NY, 2023
- L’amore apocrifo, di prossima pubblicazione
- Prepararsi alla fine, di prossima pubblicazione
- Poemi d’amor perduto, 2011-2022, di prossima pubblicazione
NEL CORPO TUO RIMORSO
I
Giorno dopo giorno
l’immenso che sprofonda in gelida fessura
il sibilo che usura l’interno e che effondeva…
II
Stabat mater bellezza e ombra della follia
e specchio giunto era il tempo che io nascessi
al lontano cammino dal lontano dove
ricurva e dolente inghiottiva l’orizzonte
ma inoltrandomi a notte e nel remo la paura
che il respiro della laguna sperdesse la rotta
colmasse la misura
III
Non posso fermarmi mi dici a una stazione
perché è a ritroso il mio viaggio già state
cucine semibuie seminferme corride di grida
latranti liturgie e dentro lo spasmo convulso
del sangue nel giugulo nel morso l’agonia
no non posso fermarmi voltarmi a ricordare
dare nome all’inaudito meglio per me l’amaro
masticare di chi non errando giudica l’errare
meglio l’amore quello normale ossia
tradire discutere se sei solo mia
e insieme accusarti del limite morale
tu stesso diviso tra bene non male
ridotto a puro avverbio il dopo e il prima
IV
Proprio vero è l’inganno il tuo logorio
verità o bellezza bellezza o verità
dimmi le cose che conoscere dovrei
e che nuda mi stringono al segreto degli altri
con cui te ne vai me in corda
alla fonda di ogni tuo umore
ma troppo sei bella ch’è alibi e dissuasione
quando il conto degli anni mi chiedi
con me sprecati tra omissis e viltà
e le altre maldicenti quella puttana
che pure col mestruo lo fa’
pardon la tua giovane età
V
Per quel poco che mi dai quanto ti perdono
ciò che insieme coniughiamo
figgere croci attender punizioni e ancora
ambivalere non vocare non potere non mai profferire
che amarti avrei voluto per le strade d’ogniddove
solamente accarezzarti e dal fondo dei tuoi occhi
col respiro dei tuoi giorni una volta adolescente
divenire indecente confinato all’infinito del tuo prato
né rimpiangere quanti anni ci dividono in coscienza
o nel corpo tuo rimorso tuo tutto presente
l’antica che inabissa e che riemerge
ventura prigionia in cui mi tenevo
una volta amore vero
VI
Misera insostanza del dolore rasternato
se al raptus ex o propter uno è sospinto
oppure se all’equivoco che crescere comprendere
il dolore del mondo significhi risolvere la colpa all’incoscienza
assolversi che il male con gli anni appena segna
ed è già via già l’oltre-galleria
quando al vero ritorno di questo viaggio
fra cose secondarie e necessarie
non dipinto né racconto solo viva continua
recitata malattia di un tempo di vergogna e di follia
quando il corpo profanato giovanile…
ma eccoci in stazione – mi distolgono le hostess
in completo verdeblu sempre pronte al bel sorriso –
sì grazie un caffè riprendo un giornale
che non leggerò
VII
Così così lontano dalla casa impossibile
nel corpo di passione irremissibile bellezza
ben oltre il confine di materia e di giudizio dirti
semplice banale mia stessa giovinezza
vorrei che le ferite più dei versi dicessero
che per te me ne andrò quando tu te ne andrai
invaso il cuore dai tuoi fantasmi
lasciate le dimore che avremmo abitato
e questo diario che tu scrivi non per me
e che io insanguino per te
IL VIAGGIO IN NORMANDIA
Per noi che partivamo
lungamente sospinti a una prossima estate
dalla neve sulle giacche dal vento dal sale
per come era pesante la schiena
e incurvata dal passo in solitario
già il nome Normandia invitava al sorriso
stringeva di speranza la mano al finestrino
Appresi alla cornetta il tragitto del viaggio
dal Nord alla Baia affondando per vigne
come dire negli anni un ritorno di affanni
un ripetere a memoria una storia d’appendice
che in qualche scaffale
e insieme annotare quanta infanzia era invissuta
quanto è inutile sorprendere ogni angolo
che s’abbia di case di pietre
tra fumi di stalle e vapori di falesie
se insieme ci si allena e ci si tempra al disamore
Ma era questo il sottinteso
completare il sussidiario con te che non parli
e che pure non ignori il vuoto spalancarsi
l’angoscia di fissare infantile in qualche foto
tutto il mondo inafferrato
che pure e ancora amiamo
Due possono viaggiare se possono incrociare
chi il cammino fa in ritorno,
i visi patriarcali silenziosi ma felici
magari aspettando che l’umido si levi
del dopo temporale
Guardavo al mattino l’orizzonte di Etrétat
strette cale d’inverno dove il freddo si scioglie
sui ricami all’uncinetto dei vetri d’albergo
sul profondo tuo dormire – pensavo
sia felice almeno questo –
e finalmente ero sereno
finalmente ero un gabbiano svernato
in quell’oceano
La donna della vita rincorsa
per le strade tra Caen e Rouen capelli biondi o neri
– è chiaro ha già sorriso è proprio qua vicino
e noi che la guardiamo ebetiti immaginando
soltanto per scherzare non certo per guastare
quel viaggio in Normandia di amaro e nostalgia
che in fondo ci piaceva
e che tutte le sere a tarda sera terminava
tra sbuffi di Gauloises e stecche di biliardo
su cosa s’è sbagliato e poi chissenefrega
E il viaggio il miraggio tutt’era inconfessato
pareva uno spettacolo spianato
giallograno verdefoglia rossoterra
e infine quel mare dove un giorno arrivammo
l’insegna del Martini la piazza la spiaggia
e lei che m’attendeva
guardando l’immenso l’azzurro
del mare di Denneville
Mesi e mesi di amore scavato nella carne
ero forse un passante nel tuo giro di morte
fingevo ma ti amavo davvero ti amavo
quando all’angolo del bar tremando mi dicevi
je sais qu’on s’est passé quelque chose
qu’ici s’est partagé…
quando a un mare lontano
e forse non a caso ti ritrovavo
sulla mia strada
Capace amico di incoscienza
sii testimone di questa ricerca
sassi raccolti su scogliere di granito
fari notturni alghe di scarpe
reti da pesca e ostriche e vetrate di bar abbandonati
maree e ritirate di spiagge e di falesie
sii testimone di quanto ho annaspato
del lavoro operoso senza salario
cazzate e risate e imbuti improvvisi
di scale e di silenzi
Tu eri là
incarnata libertà che avevo sognato
e che il mare levigava
senza il coraggio di avvicinarti
ma nel cuore la certezza che giammai
avrei scordato qual mare di Denneville
dove l’ultima volta ti avevo amata
e lasciata nel tuo male
al mio ritorno
L’uomo che ha deciso di condannarsi
così riparte
con quel poco di dolore lasciato
a un’altra volta e quel poco di gioia
– vedrai le scriverò
né spezzerò questa corda di vene che ci unisce
e poi potrò tornarci se una volta è già stata
Così la Bretagna e la Bassa Normandia
invitavano al calore del ricordo
fissavano un estremo al ritorno da grandi
con mogli sicurezze e l’incerto retrogusto
di un vino mal scelto
Ciò che andava cercato era tutto
raccolto in un angolo di casa dal tetto spiovente
di travi e di abbaini
sotto un manto di coperte
nel sonno che sorprende
mentre si ride si parla e un po’ si straparla
di donne e di avventure
E noi eravamo noi proprio i pellegrini
senza fiato a piedi nudi nelle sabbie di Genêts
traversanti la Baia che invece a un monte
sospeso guardavamo come all’ultimo traguardo
al vero da capire
un poco ingannandoci
tenendoci per mano
LA NOTTE CHE ETEREA EFFONDE
La notte che eterea effonde
creando e disfacendo il calice del mondo
l’infanzia che incombe ricorre nell’ombra
eppure non s’arrende davanti al tuo portone
il giudice che addita
la croce e la delizia del paradigma
non dolo non volo eppure bisogna
Bisogna glielo dica – solo questo aspettavo
mentre lasciavo la soglia della casa
l’interdizione antica stampata nella carne
che il figlio non possa più in alto del padre –
e lei che così morbida vestita nel bianco
assolato dei vent’anni che ormai da più giorni
all’uscita di scuola aspettava l’estate
del primo bacio dei pugni chiusi – pensavo
Signore quale distanza commette l’amore
me così in guerra lei così serena
Mio amore mio nel sogno
ho troppe e troppe cose da dirti insospese
sul filo dei secoli che ho dovuto annodare
viaggiare più veloce delle cose che sfuggono
di te che scendevi nell’ileo del sogno
di me che sul bivio ogni volta esitavo
chi sono o chi ero ma se uno all’inizio
sei felice – avesse chiesto – ch’ero troppo e leggero
e che un giorno avrei pagato
La tua follia dischiusa al sorriso
improvviso che uno al primo amore
dimostra incosciente paradiso di colori rosso giallo
e l’umido tra i petali che s’aprono sbocciata svelata
in quel lenzuolo sulla spiaggia che morbido avvolgeva
tutto il bello del mondo
e più non c’è altro bisogno né credo
sei tutto il cielo – avevi detto
le braccia levando mentre ti stringevo
mangiandoti a sbafo sentendoti gridare
affermare al tuo culmine
La tua follia di quando correvamo
vogliosi ed impazienti le scese del tuo parco
e sotto la cerniera fremente del tuo Levi’s
dicevi – non c’è niente baciamoci per strada
nel cinema all’aperto in un angolo alla metro
bagnati di pioggia d’estate ed avventati
dimènticati il padre qualunque cosa sia
è nostra la vita
la nostra follia sfilata sui sedili
la gonna e la camicia l’esposta frenesia
tu nuda e sfinita bellissima e nudata
di che l’amore sporca
di scrupolo e vergogna
ch’è adesso che ti amo e sei tu la mia gioia
presente mia storia che in te si rinnova
per cento e mille notti
ch’è adesso che ti amo
mia terra e paradiso soffiato tra i capelli
tra i seni e le ginocchia
che sfioro discopro risalgo in cui mi perdo
e tutto era insieme tua gioia mia gioia saziate
ugualmente ché ancora ti amo davvero ed ignaro
se per il tuo nome di interno berlinese
o per la mia attesa che ti aveva creata
segreto immarcescibile di colpa e di pulsione
vita aggressione
La tua follia scappare via
che importa a Milano che sia il teatro
sia la poesia sianche il diavolo
ma lasciami un figlio che almeno ricordi
che porti i tuoi occhi
Mio amore disperato e tua follia
non ero più niente eppure esistevo
per tante e tante lettere per ore al tuo telefono
– anche l’amore vi avrei fatto –
anche l’orrore l’amputazione di camere ostetriche
l’incesto la dilazione del padre della madre
qualunque copione che tu mi cucivi perché ti divertissi
perché corrispondessi a come mi volevi
– l’avessi potuto mi sarei annullata
anche per te avrei pianto
quando mi tradivi iniettandomi veleno
quando pure ogni tuo bacio per me era il primo
il giorno dopo al mattino
se solo mi chiamavi e mi prendevi
ma lasciami un figlio che viva per sempre
e che ci sia
La tua follia normale incontenuta
che il tempo annullava che il corpo e la vergogna
che infanzia infondeva per sempre ed ancora
era quello che cercavo io ero tu eri
mito incarnato riscattata morte
Franzi mio amore
non posso arrestarmi di chiamarti di sognarti
non posso che amarti in ogni terra sconsacrata
cui il vento mi spinge di insania di nevrosi
in cui ti cerco stesso corpo stesso nome
metro di misura di altro amore
pietra miliare sulla strada che ho corso
creando e disfacendo ciò che è stato interrotto
dalla tua morte e più non so vivere
il mondo è svuotato la pagina bianca
penosa ricerca il lavoro ben fatto
inutile un’altra
impossibile amore
Se uno muore è già morto
se uno ama è già amato
ma i miei giorni passano nel dubbio
che forse avrei dovuto rincorrerti all’altare
rincorrerti a scuola rincorrerti ancora
e non questa corsa finita nel mezzo degli anni
del corpo mezzo dentro mezzo fuori
nato morto morso rimorso
gioco dovere l’asfissia l’aria
tu ed ogni altra
Se ci penso quale condanna
farti fuori per amare
dover scrivere per vivere
da Nel corpo tuo rimorso, Crocetti Editore, Milano 2002
….dall’Introduzione di Rocco Mario Morano, University of Toronto Missisauga
Volendone indicare le caratteristiche fondanti e circoscriverne preliminarmente e sinteticamente le linee di ‘demarcazione’ operative, i centoventotto componimenti poetici della raccolta di Lamartora costituiscono di fatto un lungo periplo attraverso la «razionalità polisensa» – per usare una formula che riassume uno dei princìpi fondamentali della estetica dellavolpiana (cfr. G. Della Volpe, Critica del gusto, terza edizione riveduta e accresciuta, Milano Feltrinelli, 1966, pp. 85-100: 85) – effettuato con lucida determinazione ascrivibile ad una profonda angoscia sopportata stoicamente e sorretta e alimentata da un nichilismo filosofico che avvolge tutto, ovvero l’io e l’altro da sé, nella notte dei tempi, assumendo pertanto un valore universale tramite la presa di coscienza progressiva e ineludibile della «dimensione della perdita».
Va detto però che il nichilismo di Lamartora affonda le radici nella filosofia di Nietzsche cogliendone artisticamente l’espressione suprema nel momento di ‘sospensione’ della tensione estrema tra lo spirito apollineo e quello dionisiaco, momento che prelude alla rappresentazione simbolica della ‘catastrofe’ intesa quale forza motrice di una trasfigurazione, o meglio riscatto, dell’uomo che osi oggi essere unicamente uomo tragico (« […] Qualcuno […] cominciò a ballare / mimando Dioniso, a recitare la parte di se stesso prima della catastrofe. / Doveva essere bello. […] / […] / Non aveva guardato con attenzione. / Tutto il suo braccio, tutto il suo corpo, forse anche il sorriso, / era stato maschera un tempo» [ Quando uscimmo all’aperto]).
Con riferimento al pensiero contemporaneo, la visione del mondo che potrebbe, con maggiore pertinenza e adesione alle liriche di Lamartora, interpretare e disvelare il senso della Modernità quale ciclico provenire delle cose dal nulla per ritornare al nulla è riassumibile nella seguente emblematica asserzione effettuata nel 2007 da Emanuele Severino: «[…] Sin dall’inizio i mortali sono abitatori del divenir altro e del tempo; cioè abitano il nulla» (cfr. E. Severino, Oltrepassare, Milano, Adelphi, 2007, p. 19). E ciò prima di conferire una sistemazione ulteriore al suo pensiero nella recente e corposa monografia dal titolo Dike uscita nel 2015 per i tipi dell’editore Adelphi di Milano. Occorre, inoltre, aggiungere che Severino non a caso figura essere – come il recente suo libro dal titolo In viaggio con Leopardi. La partita sul destino dell’uomo (Milano, Rizzoli, 2015) conferma ampiamente – ermeneuta finissimo dell’indissolubilità di ragione e poesia riscontrabile nelle opere del grande recanatese ‘piegate’ alla weltanschauung nichilista e antimetafisica che nel Novecento sfocerà, con sensibilità e stile diversi, nella filosofia e nella poesia di Michelstaedter, passando per Schopenhauer, Heidegger e Jaspers, scopritore, quest’ultimo, in Vernunft und Existenz, delle «segrete passerelle che portano dal cristiano Kierkegaard all’ateo Nietzsche», come ha avuto modo di precisare opportunamente Remo Cantoni nel suo monumentale saggio La coscienza inquieta dedicato al grande pensatore danese (cfr. R. Cantoni, La coscienza inquieta. Sören Kierkegaard [1949], seconda edizione aggiornata e ampliata, Milano, il Saggiatore, 1976, p. 295). (…continua…).
Si incamminarono al mattino presto
Si incamminarono al mattino presto, prestissimo.
La notte era fonda.
La baia da traversare estesa, pericolosa, profonda.
Il mare li sommergeva quasi.
Non c’erano guide, né rotte sicure.
Nessuno ci aveva ancora provato.
Camminavano lenti, ciascuno con le proprie angosce,
col proprio minuscolo uomo da trasbordare.
Camminavano in silenzio, ciascuno da solo con se stesso.
Avevano cercato tutto, tranne la felicità.
Avevano trovato tutto, tranne l’amore.
Soltanto l’uomo profondamente solo
Soltanto l’uomo profondamente solo può viaggiare
nel treno di notte, senza prender sonno,
passando le ore a guardarsi nello specchio,
andare avanti e indietro nel vagone letto,
sobbalzando ad ogni scambio di rotaie,
e quando è l’alba scivolare in silenzio dal finestrino,
inghiottito fra cielo e mare
La bella estate è finita
La bella estate è finita.
Come finisce uno sguardo, un sorriso, un bacio
prima dell’addio;
come si spegne il televisore sul mondo in festa,
come si chiude una finestra, silenziosa, dietro le spalle.
La bella estate dei ritorni dal mare,
degli amori vecchi e nuovi, delle storie inventate.
Se mai un giorno ritorneremo vivi
dovremo cercarle le parole,
per raccontare cos’è stata questa felicità e questa perdita,
dopo la quale non sei più com’eri,
in piedi nel primo mattino del nuovo inverno.
da La dimensione della perdita, Crocetti Editore, Milano 2016
…dall’Introduzione di Paolo Puppa…
Una stanza vuota, o al massimo con poche suppellettili. Uno spazio invaso da segni eloquenti di degrado e di abbandono. Luce quasi inesistente. In questo milieu vago e indeterminato si leva la voce di qualcuno, a volte specificato nel sesso e nell’anagrafe (ma in prevalenza adulto o anziano), altre volte no. Ebbene, questa voce accoglie subito un tu, ricevendone stimoli e motivazioni a parlare. Lo fa con un senso di sollievo, in quanto a lungo in attesa di questa epifania. Inizia così a rovesciargli addosso un flusso di confidenze, di ricordi, di flash back regressivi risalenti all’infanzia, all’esordio ontologico nella vita affettiva. In un certo senso, la sagoma che racconta potrebbe distendersi nel divanetto dell’analista. Tanti sono infatti gli indizi di una parola clinica, disturbata nella sua narrazione compulsiva che va e viene (“non ha un filo il mio racconto”). Al centro del tutto, i nodi traumatici di un romanzo famigliare. Perché questo disarmato mon coeur mis à nu coincide con una trasparente, quasi imbarazzante, confessione privata, una rielaborazione difficoltosa di abbandoni e di lutti immedicabili. Ora, i fantasmi cui si rivolge sono in cinque casi ruoli parentali decisivi entro un’esistenza votata al dolore. Ecco i genitori troppo diversi tra loro, lei “inarrivabile e inconsolabile”, lui attaccato a una pedagogia militare, sfasati anche per la disparità economica e ambientale di partenza; poi una zia paterna, samaritana squallida e crudele, capace però di sollecitare nel nipote masturbazioni in sua presenza; quindi una moglie stanca di disomogeneità coll’ego che narra e pertanto in fuga “malamente, freddamente”; infine una figlia stordente per bellezza, come la nonna paterna. A fianco di costoro non manca Freud, la pelle devastata dal cancro terminale, ma anche dai “demoni-avvoltoi” che assalgono il suo studiolo. È solo, il vecchio patriarca, a delirare contro colleghi e allievi, a rimuginare su onanismi anali e analoghe suggestioni, annusando profumi di pazienti, e in attesa smaniosa dell’ultimo cliente, sperando di esserne toccato. Il Freud di Lamartora appare per giunta sospeso tra ricordi di iniziazioni rassicuranti in bordelli e strane voglie di amicizia virile, ben saldo nell’insofferenza per la vecchia moglie, adesso compagna inerte e depressa nel freddo letto. Ma in tal modo anche il Maestro, mentre confabula con l’allegoria della Melanconia, e si gingilla cogli oggetti del tavolo, come la lente ereditata dagli antenati rabbini, non fa altro che ribadire la comunicazione autistica dei suoi compagni di casting. Tutti in effetti sono vittime di se stessi e degli altri, e tutti allo stesso tempo carnefici. Alle spalle, pulsa la memoria di miti ed eroi antichi, scelti con cura da Lamartora durante l’apprendistato snervante negli studi classici. E l’inferno domestico, che rimanda a canonici repertori teatrali novecenteschi, basti citare Strindberg e le sue Danze di morte tra coniugi, o l’Albee di Who’s afraid of Virginia Woolf?, viene riletto alla luce della Micene di Agamennone e Clitennestra. Sono vere e proprie guerre mondiali queste, sono guerre mortali, con ferite anche letterali, occhi che schizzano fuori dall’orbita, forchette che penetrano la carne, cognati che tentano incesti, figli che bruciano il talamo dei genitori. Sì, queste vicende luttuose srotolate in un clima noir alla Bellocchio, nell’orizzonte ancora della famiglia che uccide si iscrivono nelle scene primarie, non tanto ontogenetiche ma filogenetiche, da cui ricevono significato. E di continuo spuntano personaggi, da Medea a Nausica e alla Gorgone (l’orribile nonna paterna), tutti illustri per tragicità e carisma, a invitare le creature di oggi a non dare troppo peso allo strazio che li assale, in quanto c’è già stato un prima fondante in termini assoluti. Una qualche storia leggendaria, leggibile in modo più organico e coerente rispetto ai lacerti affannosi e slabbrati in cui si macerano viceversa i poveri protagonisti nel disagio del disamore e del disincanto. Confessioni di sé, dunque, anamnesi familiare sfogliata come l’album che l’io parlante dichiara di aver ricostruito, specie per la bella Elène-Afrodite dell’ultima stazione in questa laica Via crucis. A lei vorrebbe imporre un destino di pianista, a risarcire la personale vocazione rientrata. Con lei sopratutto farnetica cambi di sesso, a diventarne madre per una più intima contiguità. I frammenti dell’album, dettagli come copertine di libri e lettere d’amore, dolci al miele ricoperti di noci, costituiscono autentiche madeleines natalizie, fungono da baluardi salvifici per l’identità, e insieme rappresentano fonte di disperazione. Solo morendo, annullandosi l’ego infatti si scioglie e può aspirare a fondersi cogli altri. Almeno così spera la prima delle voci monologanti, in It was, auspicando il futuro metafisico di “un solo battito, un corpo solo”. Ma i vari assolo si potrebbero agevolmente fondere tra loro, unirsi in un unico discorso in-finito e cambierebbe poco per la struttura dei singoli pezzi, quasi tempi musicali diversi di una narrazione poetica. Non so, per essere franchi, se la bocca di attori in carne ed ossa e anche l’orecchio di spettatori abituati al telecomando potrebbero sostenere tanto accanimento contro il silenzio. E nondimeno se alla televisione sostituiamo appunto un palcoscenico, ecco che il quadro trova la sua naturale cornice. (…continua…)
It was
(Scena vuota. Quasi buio. Nessun oggetto. Nulla di concreto o di realistico.
Al centro, un area quadrata, soprelevata rispetto alla scena circostante – quasi fosse una stanza, un letto coniugale, un luogo isolato sospeso sul mare, sul nulla -, le cui pareti sono vetrate, nude, trasparenti, create dagli effetti delle luci. Tali pareti diventano specchi o vetri trasparenti a seconda dell’angolo di incidenza delle luci di scena, proprio come avviene col rifrangersi del sole su una finestra. Il mare o il nulla, su cui la stanza galleggia, ha una tonalità fredda, azzurra, anch’essa creata dalle luci
Il dramma si svolge interamente in questa stanza.
Una donna, appena vestita di bianco, muove le labbra, come dicendo qualcosa a se stessa. È pallida, emaciata, ha un’età indefinibile, comunque anziana. Il vestito pare un abito di scena, una veste regale portata elegantemente, benché logora e impolverata. Dal portamento, parrebbe essere stata un’aristocratica, rigorosa e altera.
Si muove lentamente, compiendo gesti enigmatici; accanto a sé, nella stanza, un coccio di creta, ripieno di cera (di cui si ricopre), una panca, una plancia o qualcosa di simile a una sedia, una tavola o un letto; una coperta grigia è poggiata in un angolo. Dall’inizio alla fine, la sua voce si sovrappone a suono continuo, basso, che attraversa l’azione senza mai interrompersi, benché variando di intensità – ora impercettibile ora sensibile, ora intenso -.
La donna si rivolge a un interlocutore invisibile – il suo compagno? Un amico? Chi altri? -, si siede accanto a lui, su di lui, lo chiama accanto a sé, si muove – insomma – come se ci fosse realmente. La bianca signora comincia a parlare:)
Vieni, entra, accomodati. Vieni pure.
Sto parlando con me stessa, come vedi,
ed è la prima volta che riesco a corrispondermi.
Si impara sempre tardi, troppo tardi, a invecchiare,
o almeno a concentrarsi sul momento della morte.
Non è una scelta, per niente.
Nessuno sceglie l’assenza d’amore, di tempo, di bellezza.
L’assenza. È ciò che rimane.
Basta che mi guardi intorno.
Non c’è più niente e nessuno, qui…
Una casa ormai svuotata, trasparente, senza difese,
costretta ad osservare al di là di se stessa o dentro se stessa,
un vuoto assordante, la quiete.
Manca poco, d’altronde.
Tra poco tornerò nel buio della profondità,
dove le cose si presentano veraci e deformate
– una bocca spalancata dai denti minacciosi;
un occhio inespressivo e liquefatto; un sesso enorme,
senza capo né coda -;
una deformazione preparata, nel mio caso, dalla nascita,
dalla vergogna, dal desiderio, un desiderio inappagabile…
Capita, quando vivi da sola, di allucinare su te stessa,
ingigantire, deformare o far sparire a piacimento
una bocca da baciare, un padre da ammazzare,
una madre dal seno prepotente ed ingombrante.
Capita, quando resti da sola.
Ho trascorso la mia vita giovanile a interpretare
la scena iniziale di un film
sulla perdita e la nostalgia nel quale io t’aspetto sulla porta,
e tu arrivi raggiante, pieno di vita: “Vieni, entra, accomodati”!
Allora tu entri, ti siedi, cominci a tremare, mi abbracci,
mi dici che in fondo l’amore tra noi due non è finito,
che è ancora come prima, ch’è ancora… ancora… ancora…
Non sei più ritornato!
Troppe volte l’ho interpretata questa scena tra me e me,
benché sia stata consapevole, sempre, che fosse appena un film.
Non mi è mai piaciuta l’esistenza; ho dovuto fantasticare,
sempre, per ridare quell’aspetto di bellezza e continuità
alla mia vita banale…
Ricordi la mia prima vecchissima amica del cuore?
Aveva la stoffa della diva, lei, bella, creativa, inquieta….
Per dieci o quindici anni non ci siamo mai lasciate,
nemmeno per un giorno;
se lei si vestiva di viola, io mi vestivo di viola;
se lei comperava una trousse, era per giocarci con me;
se una s’innamorava, anche l’altra cominciava a tremare…
ci siamo sostenute, confidate, scritte e descritte;
abbiamo studiato, viaggiato, festeggiato, tutto insieme,
fino a quando lei non ha incontrato il suo… principe azzurro!
Da quel momento in poi, più nulla!
Telefonate, appuntamenti, vacanze: nulla!
In quell’uomo, tutta l’inquietudine e il sacro suo furore
s’erano mutati nell’inerzia della beatitudine.
Sembrava drogata. Che invidia!
Certe donne rivelano la loro vera natura al riparo
di una coperta matrimoniale,
sotto la quale hanno avuto la fortuna di restarsene a sognare,
trasognare, a regredire.
Coperte da quell’abbraccio rassicurante, così a lungo rivendicato,
il loro viso si rattrappisce, lo sguardo si fa opaco,
le palpebre si chiudono, il seno e i capezzoli scompaiono,
tutto il corpo rimpicciolisce, rimpicciolisce, rimpicciolisce,
fino a diventare nuovamente delle bimbe,
consegnate tra le braccia del papà.
Che invidia! Che meraviglia!
Ebbene, quando doveva venire a trovarmi mi sfiancavo
a imbellettare la casa,
a rimettere i centrini sotto i vasi di orchidee;
accendevo l’abat jour; preparavo l’incenso,
mettevo fuori frigo quel cheese cake che amava tanto.
Poi… Poi il tempo passava, lentamente; la pellicola scorreva,
ed io restavo lì, dietro la porta, ripetendo a bassa voce
il mio perenne benvenuto: “Vieni, siediti, accomodati…”.
E invece niente; non succedeva niente, non arrivava nessuno,
tanto che la ripetizione di quell’unico identico fotogramma
dava l’impressione di un’istantanea, di un immagine
ferma e sfuocata, anziché di un film!
E mio fratello? Quanto l’ho aspettato di trovare, mio fratello,
di incontrare un compagno con cui scorrere le estati a sollevarci
l’uno e l’altra,
raccontandoci con cura di come si fosse sgretolata
la nostra famiglia e l’infanzia,
e così trovando una ragione, un senso fondativo a questo
sentimento della perdita che ci avvolge, ci compenetra,
come la nebbia nel buio di una foresta.
Chi altri, se non un fratello, avrebbe potuto testimoniare
lo sconcerto e il dolore di trovarsi da soli, indifesi,
nel bel mezzo di una guerra ventennale di cui ignori le ragioni,
le conseguenze, le parti in campo?
Chi meglio di un fratello avrebbe potuto testimoniare
che una guerra c’è stata,
sostenermi a buttar via queste armature che abbiamo ricevuto
in eredità,
questi attrezzi inamovibili lasciati a arrugginire
nel nostro giardino?
Quando prometteva di venirmi a trovare,
mi preparavo col vestito migliore; gli preparavo l’accoglienza
migliore, di modo che anche lui potesse avere una famiglia,
anche lui che una famiglia non l’aveva ancora avuta…
Ma il mio adorato fratello aveva scelto da tempo
di non guardarsi più indietro, per sopravvivere, certo;
aveva scelto di puntare con tutte le sue forze sul futuro,
sul futuro di una casa e di un amore coniugale impermeabile
a chiunque le avesse rievocate – quella guerra e quelle armature -,
sotto i cui fendenti anche egli aveva perso la parte più bella
del proprio corpo, del sorriso, della vitalità.
E io ero, soprattutto io, la testimone, l’aedo da scansare,
l’alter ego da rimuovere.
Nemmeno lui è più arrivato.
Dopo mia madre e mio padre; dopo il primo e ultimo amore;
dopo le amiche più care, nemmeno mio fratello è più tornato.
È andata così.
Nessuno è più venuto da me per chiacchierare, per rapirmi,
o almeno accomodarsi.
Nessun familiare che abbia avuto la dignità di tornare
ad onorarmi da regina, quale ero
– benché il mio regno fosse stato piuttosto un calco
di qualcosa che avrebbe dovuto esserci e non c’era,
e benché il mio scettro l’avessero rubato le nostre servitrici,
così invidiose della mia inafferrabile bellezza -;
nessun amante che abbia avuto l’ardire o il desiderio
di guardarmi da donna,
proprio adesso che son vecchia, di cercarmi sotto l’abito da sera,
di stendermi su un letto, chiudermi gli occhi,
baciarmi sui fianchi, da vecchia, adesso…;
nessun amica che abbia avuto la pietà o l’incoscienza
di mettersi qui, vicino a me,
a contemplare in silenzio la sparizione misteriosa e progressiva
di questa casa dalla quale sono sparite, per conto proprio,
le tende alle finestre, le lampade, gli armadi, gli utensili ordinari,
finanche le mura divisorie, tutto…
eccetto questo fascio di luce che ci svela, ci attraversa,
come un giavellotto ficcato nella schiena.
Per questo – ti dicevo – sono stata tralasciata e isolata.
Oppure sono io che mi sono isolata, va a sapere,
troppo diversa, timidissima, incostante.
Quand’ero ragazza, mio fratello e mio padre, si svegliavano
di buon mattino per rasarsi, profumarsi e imbellettarsi,
non vedendo l’ora di uscire di casa, raggiungere la scuola
o l’accademia, o anche un’alcova,
un posto in cui indossare la propria identità,
una muta subacquea impermeabile ed anonima, senza fessure -;
mi infastidiva quella loro frenesia, ero invidiosa della loro sicurezza.
Io invece mi ero ritirata dalla società, non perché mi sentissi
migliore, anzi, per pigrizia,
o forse per la consapevolezza prematura che ogni interesse,
ogni occupazione non sarebbe più servita a liberarmi
da me stessa, ad assolvermi dalla dipendenza che a qualcuno
mi legava, sempre, anche quando nessuno c’era…
Mi vergognavo dell’indolenza, la timidezza,
la mia stessa bellezza;
non avevo nulla da conquistare o presidiare, io.
Fosse stato per me, sarei rimasta una fanciulla, avrei buttato
il mio tempo
a rincorrere farfalle, immergendomi nei fiori di magnolie,
di wysterie, dei lillà che d’estate risalivano dai prati;
me ne stavo nel mio letto fino quasi a luce alta;
era un giaciglio per me, un posto mio, vi indugiavo con piacere,
proprio senza vergognarmene…
Isolata in quella culla quotidiana, mi applicavo ad assolvere
a quel compito che io stessa m’ero dato:
trasformare tutta la rabbia, circolata nella famiglia
in qualcosa di buono e riconosciuto; riportare il sorriso
su quelle maschere da sfingi che i miei indossavano
continuamente,
colorarle di rossetto, di modo che apparissero più allegre.
Mi era indispensabile quel lavorio, tutto immaginario,
quel sorriso al quale affidavo la risoluzione magica
di ogni conflitto!
Pareggiare i conti con mia madre e con mio padre
era il passo necessario, prima ancora di sorridere,
di vivere, di uscire.
Quel ruolo di mediatrice mi si addiceva,
proprio per la mia riconosciuta sensibilità e doppiezza,
anche se mi sarebbe costato la semplicità,
l’integrità e l’amore, innanzitutto…
Che cosa enorme l’amore – non pensi? -, robusto, bello…
Un albero di rose, sostenuto da migliaia di radici
contraddittorie, fiorito da migliaia di boccioli variopinti,
così esposto alle intemperie, all’abbandono, ai bucherons.
Ero stata concepita per l’amore, io
– forse anche il matrimonio, come dicevano altri -;
non facevo che pensare a un bel ragazzo, fin da bambina,
uno di quegli atleti affascinanti e tenebrosi che affollavano
il liceo,
con cui fantasticavo di commettere serate sul bordo del mare,
tra lettere sentimentali e parole infuocate,
un piacere dei corpi avvolgente e duraturo quanto la fedeltà.
Ricordi? Una delle prime poesie che trascrissi per te
era quella sull’edera…
E come sempre, quando cerchiamo avidamente la mano
di qualcuno che ci completi,
l’amore arriva presto, per nulla inatteso.
Anche tu sei arrivato, fin troppo presto, i riccioli castani
e morbidissimi, lo sguardo premuroso e coinvolgente,
l’intelligenza acuta; una borsa di progetti e giuramenti:
stare insieme, lottare insieme, invocare un figlio nostro,
viaggiare, dipingere, giocare, desiderare il desiderabile…
Quanta determinazione in quelle promesse; quanta verità,
quanto coraggio nel debutto con cui affrontasti mio padre
e mia madre,
dicendo loro che “la forza è un surrogato dell’intelligenza”!
Me lo ricordo ancora!
Sembravi Ulisse, Ettore, quegli eroi non dominabili,
nei quali la passione parla al posto della realtà…
D’altro canto, onesto lo sei sempre stato,
non è per questo che è finita; non è per mancanza d’amore
o di coraggio nel combattere al mio fianco;
non è per negligenza o incomprensione che te ne sei andato.
Ero io purtroppo a non essere all’altezza, del tuo amore,
della tua dedizione. Incerta, troppo divisa, complicata.
Anche quando riconoscevo il disperato bisogno di te
non sapevo domandarti né amore né aiuto;
mi richiudevo nella mia superba insufficienza,
aspettando che tu mi fossi accanto a contemplare,
a testimoniare ciò che io soltanto potevo fare;
quella storia di famiglia mi aveva assorbita,
reclusa dentro un buco impenetrabile del quale ero guardiana,
io stessa, di fronte al quale non permettevo a nessun altro
di fiancheggiarmi, anche se, al tempo stesso, mi lamentavo
della tua… lontananza!
È per questo che te ne sei andato, credo, lontano, impotente,
logorato, anche se ho sempre pensato che ci saresti rimasto,
dentro di me, e forse illusa che saresti ritornato…
Ho sprecato la giovinezza, dunque, a cercare di comprendere,
– o almeno mitigare –
l’incomprensibile livore di quei giganti che attraversavano
la nostra casa,
calpestando tutto ciò che incontravano sul loro cammino.
Nessuno l’aveva proclamata, quella guerra,
ma una guerra pure c’era.
Non restava che imparare, e presto, a distendersi per terra,
sotto il tavolo da cucina, lungo il muro del corridoio,
a sdraiarsi come un morto, sperando che almeno da morti
si possa rimanere concentrati su ciò che vorremmo
essere e sognare.
(…….continua…….)
….dal Saggio Critico di Mario Rocco Morano – University of Toronto Missisauga
(…) La scrittura, in Lamartora, assume il valore di un estremo tentativo di documentare e ordinare il «processo di individuazione»:
[…] / Nulla che rimanga si può scrivere adesso. / A meno di allontanarsi dalla sabbia / e inoltrarsi verso l’interno.
E dalla sabbia – come si sa – emergono secondo Jung simboli del Sé «accompagnati da sentimenti profondi e intensi».
Essendo l’ossessione dell’orfismo della parola ormai svanita del tutto, occorre, senza lasciarsi sopraffare o opprimere dallo sgomento e dall’angoscia e senza arrovellarsi nella ricerca inutile del ‘perché’, mettere in conto e accettare di vedere dinnanzi a sé la ‘pagina bianca’ e saper tacere o starsene in silenzio, soprattutto quando si è consapevoli del fatto che paradossalmente spesso è «il giorno andato a male» a far trovare «il momento giusto […] per scrivere poesie».
Questa forma estrema di diario intimo e di ‘quotidianità’ altalenante del vissuto – come quella, precorritrice per certi versi del crepuscolarismo novecentesco, praticata in Italia da Vittorio Betteloni a partire dal secondo Ottocento in perfetta consonanza con il fenomeno di diffusione in Europa, e in particolare in Francia, della esthétique d’en bas, dalla quale Lamartora sembra aver intelligentemente attinto elementi di ispirazione attualizzando in chiave psicoanalitica i principi fondanti della sua poetica – è rivelatrice di una ricerca di senso avvertita innanzi tutto come moralmente necessaria, ricerca il cui percorso viene indicato e illustrato nel testo poetico ricorrendo a un ‘minimalismo’ tematico ed espressivo per nulla intimistico al di là delle apparenze, ma frutto di una scelta deliberata volta a ‘caricare’ di significati profondi, dal valore eminentemente simbolico, la lingua del parlato comune.
Insomma, privato dell’aura della ‘sacralità’ vaticinante e del substrato di un astratto ‘furore’ creativo e immaginifico, aura che fino a tempi non remoti gli ha conferito in letteratura e in società una sorta di primato, il poeta si ripiega su se stesso non per narcisisticamente ‘autocontemplarsi’, ma per estrarre dalle proprie esperienze – con l’ausilio di un procedimeno di natura selettiva messo in pratica con rigore quasi ‘classificatorio’ – determinati ricordi e rievocazioni di luoghi, incontri, delusioni, sensi di smarrimento e solitudine, drammi esistenziali e familiari, sedimentati nell’inconscio personale e ai quali vanno aggiunte le «possibilità di rappresentazione» trasmesse in modo ereditario e da Jung definite «Archetipi», costitutivi dell’«inconscio collettivo» e affioranti alla coscienza mediante le «Immagini Archetipiche» sotto forma di fantasie, sogni e visioni, applicando su di sé la tecnica della «Immaginazione Attiva». E scarnifica al massimo il linguaggio per un desiderio insopprimibile di comunicazione diretta e immediata che è frutto di uno studio assiduo volto al conseguimento, sulla scia dell’insegnamento del Castiglione, di una forma di ‘sprezzatura’ rinnovata e attualizzata agli albori degli anni Settanta del Novecento da Cristina Campo prima di essere da Lamartora consapevolmente o per fortuita coincidenza adattata alle proprie esigenze artistiche e alla propria visione del mondo nelle seguenti riflessioni sulla poesia risalenti al 2016:
Il poeta […] non deve inventare nulla. La creazione artistica, svincolata dalla realtà, è puro esercizio di fantasia. Allo stesso modo la poesia deve essere comprensibile. Semplicità, quindi. Ciò non equivale a banalizzazione, ma, anzi, a perfezione. […] Continuo a pensare, quindi, che la poesia debba richiedere al poeta una disciplina, un sacrificio umano e morale, che è quello di rinunciare alla celebrità, alla ricchezza, alla felicità, in direzione del senso. Trovare luoghi da “fotografare”, stagioni, teatri di guerra, emarginazione di umanità che siano di utilità umana e sociale. Anche qualcosa da dire e da esprimere […] (…continua…)
Talvolta, nel bel mezzo di una festa
Talvolta, nel bel mezzo di una festa,
di un giorno qualunque,
mi coglie la sorpresa di un brivido,
la sensazione di aver concluso nulla.
Mi prende un impulso, oscuro.
Vorrei scappare, sparare, sparire.
E così accade.
Il suono squarcia l’illusione.
Riporta le cose così com’erano,
al grado zero di ogni mattino,
quando mi sveglio, mi stendo,
e con la mano l’avverto che il letto è vuoto,
che tu, l’amore, poesia, la vita.
Tutto finito, consumato.
Risolto.
Come tutti io potrei ammazzare
Come tutti, io potrei ammazzare.
Ammazzare in modo premeditato o casuale,
una bestia, un cucciolino, un uomo indifeso.
Come tutti, mi rifiuto di pensare che posso ammazzare,
che riesco a ammazzare.
Come tutti, reagisco con violenza a chi mi addita come un mostro,
dico che mi conosco, non l’ho mai fatto, nemmeno ci penso.
Ecco. È questo il punto, certo.
Non pensarci mai,
non avere mai varcato la soglia della caverna,
dicendosi sicuri di non esser Polifemo.
Chiudi la lampada
Chiudi la lampada, mi dico, vattene a letto.
Cerca di raggiungere tua moglie, tua figlia, quelli normali.
È già passata la mezzanotte.
Cosa vuoi che aggiungano due chiacchiere, ancora,
a una vita sbagliata fin dall’inizio, e mai vissuta.
da Disamore, La Vita Felice, Milano 2017

……..dall’Introduzione, di Giannino Balbis
Credo sia opportuno iniziare la lettura di questa nuova raccolta di Enzo Lamartora da “Scrivi in modo comprensibile” che, in chiave di monito rivolto dal poeta a se stesso, dichiara la poetica da cui muovono e verso cui tendono le liriche di Attendersi di là e su cui si fonda, a ben guardare, l’intera produzione di Lamartora. “Scrivere in modo comprensibile” soltanto “di ciò che si è sofferto”: non si possono delineare più chiaramente e nettamente di così i perimetri formali e contenutistici di un progetto letterario. Prima c’è la vita, con la verità delle sue labili conquiste e delle sue perdite più dolorose, i suoi brevi sorrisi e le sue lunghe pene; poi c’è la poesia, che di tutto si fa carico, in piena e sincera confessione, con la ferma volontà di chiarire, comprendere, superare. Non poesia per se stessa, dunque, non quella che cerca la gloria nell’applauso dei dotti, ma una poesia-fiore capace di superare l’inverno, di disseminare per aria / la parte migliore del suo creatore. Così – soltanto così – la voce di una singola vita, di una sola anima può sperare di diventare un giorno la voce di tante vite e tante anime. Misterioso e miracoloso destino della vera poesia.
Tema conduttore della raccolta, quindi, è un processo di distillazione di senso da ciò che si è patito o sofferto: le sconfitte grandi e piccole di ogni giorno, i conti che continuamente si aprono e restano da saldare, le voragini di solitudine che lasciano le partenze senza ritorno delle persone più care. La raccolta appare così come una lunga richiesta-promessa di appuntamento oltre la vita, oltre il tempo: l’appuntamento in quel non-luogo e non-tempo in cui è possibile riannodare ciò che la morte divide, mantenere congiunte le anime, conservare il bene che anche le perdite supreme possono produrre in termini di valori e sentimenti. È un di là imprecisato: sembra a tratti quello saldo della fede, a tratti quello di una timida speranza carica di fragilità umana, a tratti quello dell’illusione prodotta dall’onda troppo lunga del dolore. Un aldilà definibile probabilmente solo in negativo, come rovescio dell’aldiqua, come assoluto bisogno di una dimensione altra: e dunque solidamente esistente in quanto tale, proprio perché privo del riscontro oggettivo di cui abbisogna la realtà apparente del qui-ora. (… continua…).
Uscendo di casa
Uscendo di casa
sentii un profumo fortissimo
fruttato, trascinante.
Gelsomino forse,
un corpo nudo,
il fresco del bucato appena fatto.
Chiusi gli occhi,
feci cadere la risma dei fogli
che avevo tra le mani.
Ero lontano ormai,
leggero, distaccato.
Potevo tornare a sognare,
tornare all’amore, ai vent’anni.
A domani.
Dopo l’inverno, l’estate
Dopo l’inverno, l’estate.
Dopo il disamore, l’amore.
È il ciclo delle stagioni
che si rinnova.
Sotto la gronda,
già vedo due rondini
rincorrersi nel vento,
ricamare che è vero
che la vita ritorna.
Mia figlia
Mia figlia mi tocca, di notte,
col suo morbido braccio.
Si stende nel letto, si rotola, si allarga,
come se io non ci fossi.
Oppure, come se ci si potesse scambiare
di corpo, di spazio, di sogno.
Attendendo che Orfeo
Eccomi qui
Eccomi qui, di nuovo,
nella casa dell’infanzia
la sola che ho amato, mi ricordi.
Forse.
Ma qui le cose sono leggere.
Un ragno s’arrampica sopra la tenda,
sapendo di non essere temuto;
la polvere si posa sui mobili
senza destare occupazione.
Qui le cose capitano all’aria,
lente, appena riscaldate dal sole;
qui il tempo può fare il suo corso,
andarsene e tornare,
sbiadire ed ammalare, senza scalpore.
Tu dici solitudine.
Io parlo di altro amore.
Finita l’estate
Finita quest’estate, dovremo cambiare.
Troppo lungo è l’inverno,
troppo lunga la distanza
tra un viaggio e l’altro,
tra un mare e l’altro,
tra me e te.
Lasciamo perdere le navi d’altura.
Forse le barche potranno bastare,
per essere felici.
………..dall’Introduzione.
Rosso. Interludio è una fotografia impietosa dei conflitti che attraversano i rapporti coniugali. È una scena da un matrimonio, un film in bianco e nero, alla maniera di I. Bergman.
In essa, vi sono due interlocutori: la voce narrante, l’Io, e l’altra. Lui e Lei. Due prede finite nella trappola delle relazioni d’amore; due volatori caduti nella rete della quotidianità, nella quale non c’è altro da fare che guardare freddamente alla propria mutilazione e a quella dell’altro. La macchina da presa del poeta si stringe sull’interno della stanza dove i coniugi feriscono, tradiscono, si tirano in faccia tutta la crudezza della verità, si rinfacciano la mancanza di tempo, di fortuna, di senso. Ognuna di queste parole, scagliate e laceranti, è una poesia, dura come una pietra tagliente. Ballast, come avrebbe potuto chiamarla l’Autore.
Il tono affettivo dominante della raccolta è quello della crisi, espressa nel modo silenzioso di Bergman, nel modo compresso di Strindberg, di Ibsen. Rosso è “quel sangue rappreso, che asciuga nelle vene, che non vedi”. Dunque, una lacerazione, una crisi che diventa un processo patologico interno, vissuto nella carne. Un male primordiale, quando si ha solo un grido per esprimersi, il riso o il pianto. Quando non si ha che una reazione di fronte all’angoscia: scappare o aggredire.
In Rosso. Interludio, prosegue la ricerca poetica cominciata ne La dimensione della perdita, dove il canto, l’incanto e la musica della prima raccolta, Nel corpo tuo rimorso, erano già svaniti di fronte alla perdita, alla dimensione pervasiva di una perdita che non è solo reale ma anche psicologica e simbolica, ovvero non riguarda soltanto gli oggetti esterni, quanto e soprattutto il senso, l’incanto, il sogno, la speranza, l’illusione, la sorpresa, la meraviglia.
Ma qui, in Rosso. Interludio, la leggerezza e l’incanto aurorali della poesia diventano gravità minerale, si concretizzano, diventano pietrisco (…continua…).
Sono un volatore
Sono un volatore.
Trasmigro tra le nuvole nere dell’oblò
quando il mondo dorme.
Son costretto a volare, certo.
Presto o tardi, l’inverno ricade sul nido,
e allora bisogna tornare indietro,
trovare un comignolo.
Dire che il viaggio è stato duro non è corretto.
Ma che ad ogni stagione si perdano
voci e baci e incontri, questo sì che è vero,
e non è poco, l’incerto.
Stavo per scrivere “rosso fine”
Stavo per scriver “rosso fine”.
Come titolo pareva efficace.
Rosso è quel sangue rappreso
che asciuga nelle vene.
Dopo la guerra, dopo le ferite.
Rosso va bene allora. Non lo vedi.
Secoli interi di solitudine nascosta dai vetri,
venti di aquile che sferzano il cielo
e ancora siamo qui a litigare,
però della fine – dici – non voglio parlare.
È appena un lampo questo sorriso?
È appena un lampo questo sorriso?
Questo brivido che mi hai lasciato
sotto il tetto, così, salutandomi?
Perché io invece mi riparo da un temporale,
mi preparo per l’amore e per il male.
Cado. Mi illudo. Cado.
Cado. Mi illudo. Cado.
È questa l’altalena della vita.
In questa solitudine continua
mi giro, e non trovo il tuo sguardo.
Se vuoi trovarmi, cercami dove non sono
Se vuoi trovarmi, cercami dove non sono,
dove non dovrei stare, non dovrei dire,
non dovrei fare.
Probabilmente è lì che mi trovo,
con tutta la verità che nascondo.
La prima volta che ho capito
La prima volta che ho capito
di amarti davvero
è quando ti stavo tradendo
eppure a te pensavo.
Oppure è un interludio tutto questo
Oppure è un interludio tutto questo,
sì, ci voglio credere.
Appena mi guardi dimentico tutto,
appena mi tocchi, mi chiami, sorridi.
Sei la rosa bagnata in cui torno,
e io sono il drogato di sempre.